Quando finisce la Repubblica, la mafia resta. E tratta.
Dalle urne alle stragi: come il potere ha cambiato volto senza perdere il controllo
Nel capitolo sui rapporti tra Cosa Nostra e l’ex Psi abbiamo ricostruito, attraverso il racconto di Luigi Ilardo, un’alleanza fondata su voti, favori, silenzi giudiziari e sangue. Ma quella storia è solo un pezzo della trama. Per comprenderla davvero, bisogna legarla a quello che succederà appena quel patto viene rotto. Quando la Prima Repubblica cade e con essa crollano le reti di protezione istituzionale che per decenni hanno garantito alla mafia impunità, appalti e sopravvivenza.
Il vuoto lasciato dalla Prima Repubblica
Paradossalmente, mentre Mani Pulite decapitava il sistema dei partiti, anche la fazione mafiosa, capeggiata da Totò Riina, si ritrovava orfana di quei referenti politici e giudiziari che per decenni avevano garantito “aggiustamenti” dei processi e interferenze nei vari gradi di giudizio.
Del resto è cosa risaputa che dai tempi dello sbarco americano in Sicilia, la mafia aveva sempre avuto contatti con le istituzioni, contatti che garantivano coperture giudiziarie e interventi politici.
Ma con il maxiprocesso istruito da Falcone e Borsellino, celebrato proprio nel pieno della crisi politica nazionale, Cosa nostra si ritrova scoperta: non ha più appoggi nei partiti in frantumi, né nella magistratura, che nel frattempo ha ritrovato un’autonomia sconosciuta da decenni. Falcone stesso, al Ministero di Grazia e Giustizia, riesce a scavalcare Corrado Carnevale, detto l’“ammazzasentenze”, riformando la composizione delle sezioni della Cassazione.
La mafia tenta un’ultima carta: corrompere il giudice Antonio Scopelliti, chiamato a sostenere l’accusa in Cassazione contro Riina e i suoi. Scopelliti non cede. E viene assassinato a Campo Calabro, con l’aiuto della ’ndrangheta. Quando fallisce anche quest’ultimo “aggiustamento”, Riina passa alla vendetta.
L’eliminazione dei vecchi referenti: Lima, Guazzelli, Andò
È l’inizio della mattanza. A cadere per primo è Salvo Lima, storico referente democristiano. Poi uno dei cugini Salvo, esattori palermitani. Segue Antonino Guazzelli, carabiniere e uomo di fiducia di Calogero Mannino: risultò a tutti chiari che quell’omicidio sembrava un chiaro messaggio indirizzato all’onorevole democristiano.
Le minacce si allargano a Giulio Andreotti e la sua famiglia, a Salvo Andò, storico mediatore del PSI con la mafia nella Sicilia orientale. Quella stessa classe politica che un tempo trattava, ora è nel mirino.
A questo punto, nel panico, i politici superstiti cercano un contatto con Cosa nostra. Si muove il ROS dei Carabinieri, con Mario Mori e Giuseppe De Donno. Si riattiva Vito Ciancimino.
Nasce così la trattativa Stato-mafia.
Il papello, Conso, e il colpo di Stato silenzioso
Le richieste della mafia vengono formalizzate in un elenco: il Papello.
In cima: la revisione del maxiprocesso e la cancellazione del regime 41-bis.
Il nuovo ministro della Giustizia, Giovanni Conso, si presta al gioco. In piena notte firma la revoca del regime di detenzione per circa 300 boss sottoposti al 41-bis.
Nessuno ne parla. La stampa non sa. Ma Riina, anziché calmarsi, alza il tiro:
“Si sono fatti sotto”
dice con disprezzo ai suoi. Non gli basta. Vuole di più. Vuole un nuovo patto.
Dall’incontro al bar Doney al patto con Forza Italia
Secondo Spatuzza e altri collaboratori di giustizia, il nuovo patto viene siglato a Roma, al bar Doney, nei pressi di un congresso di Forza Italia. Lì, un emissario della famiglia Graviano incontra un politico vicino a Silvio Berlusconi, forse Marcello Dell’Utri.
L’accordo è chiaro: protezione politica in cambio di voti e stragi.
Si torna alla “strategia della tensione”. Nasce la sigla Falange Armata, pensata per depistare e spostare le responsabilità su fantomatici terroristi.
“Abbiamo l’Italia in mano tramite quello delle televisioni”
confida Giuseppe Graviano.
La macchina si mette in moto. La mafia uccide. Forza Italia stravince: 61 a 0 in Sicilia. Berlusconi va al governo. Ma Riina, ormai ingestibile, diventa un peso.
L’era Provenzano e l’omicidio Ilardo
Lo Stato sceglie un interlocutore più morbido: Bernardo Provenzano. È lui a consegnare — o a lasciare consegnare — Riina, Bagarella, i fratelli Graviano, Santapaola.
In cambio ottiene l’invisibilità. Provenzano non si tocca. Non si arresta neppure a Mezzojuso, dove lo protegge una rete di coperture istituzionali e massoniche.
Si dice che venga persino curato in Francia con l’intervento del dottor Attilio Manca, poi trovato morto in circostanze sospette.
Attilio Manca urologo ed esperto luminare nelle operazioni alla prostata tramite laparoscopia, sarebbe colui a cui lo Stato chiese di operare Provenzano in una clinica francese.
Attilio Manca viene ritrovato morto nel suo appartamento di Viterbo e le cause della morte vengono addebitate ad un’overdose che il Manca si sarebbe iniettato. Anche le autopsie e i processi successivi stabilirono questa causa sebbene era evidente a tutti che Attilio Manca fu vittima di omicidio, camuffato malamente da suicidio. Altissime Istituzioni avrebbero avallato questa tesi con interventi diretti sui giudici di Viterbo.
Fu trovata anche una persona, Monica Mileti, che in primo momento dice di essere stata lei a fornire lo stupefacente al Manca e viene condannata per questo.
Ma la stessa Mileti, in seguito, com’è noto, ritrattò tale dichiarazioni e fu completamente assolta perché il fatto non sussiste.
Ancora oggi la mamma di Attilio, chiede giustizia per l’omicidio del figlio che in tanti anni non è mai arrivata.
La sensazione che si nutre sembrerebbe di essere dinanzi una vicenda segnata da macroscopici errori e da interferenze che sembrerebbero giunte perfino dalle più alte cariche dello Stato.
Ma anche su questa vicenda torneremo a parlare.
Non solo Provenzano: anche boss locali come Santapaola vengono tutelati.
Ricordiamo la farsa della sparatoria di Terme Vigliatore, che permette a Santapaola di fuggire, salvo poi essere arrestato solo quindici giorni dopo, dalle squadre della Polizia di Stato (SCO) guidate da Antonio Manganelli, che da lì a poco diventerà capo della Polizia.
Anche su questa vicenda dell’arresto di Santapaola sembrerebbe che ci sia stata una clamorosa delazione, ancora oggi mai chiarita, del braccio destro di Aldo Ercolano.
Anche la vicenda del “pacco di biscotti” che emerge dalla deposizione di Santo La Causa, uno dei killer di Ilardo che rivestiva un ruolo di vertice dentro l’organizzazione di Santapaola e che decide di collaborare con la giustizia.
Fu proprio La Causa che rivelò che l’urgenza di uccidere Ilardo arrivò dal carcere attraverso un bigliettino nascosto dentro un “pacco di biscotti”.
Lo stesso Maurizio Zuccaro, anch’esso condannato all’ergastolo per l’omicidio Ilardo, dice tra i denti che La Causa portò questa notizia e accenna al “pacco di biscotti” senza assumersene la paternità e lasciando intendere che erano cose che diceva La Causa.
Luigi Ilardo, che ci aveva portati ad un passo dalla cattura di Provenzano, viene lasciato senza protezione e ucciso prima di entrare nel programma di protezione. Era la voce che avrebbe potuto rovesciare il tavolo. E lo Stato — ancora una volta — ha voltato la testa.
La persecuzione degli onesti
Chi aveva provato a impedire tutto questo? Chi aveva raccontato le trame?
Michele Riccio, Gioacchino Genchi, Saverio Masi, Carlo Pulici, Mario Ravidà e il collega Arena e tanti altri investigatori.
Riccio non solo è stato isolato ma anche arrestato. E lo stesso Riccio che aveva portato lo Stato ad un passo dalla cattura di Provenzano nel 1995 grazie alle rivelazioni di Ilardo.
Genchi perseguitato con diversi procedimenti giudiziari alla fine è stato destituito dalla polizia in altri termini è stato licenziato.
Vittima del sistema anche l’ex finanziare Carlo Pulici, che aveva lavorato per dieci anni con la dott.ssa Teresa Principato, a cui spariscono i computer dalla procura dove erano contenuti gli atti che aveva fatto con la Principato. La vicenda denunciata dal Pulici non hai mai avuto un seguito anzi il Pulici alla fine è stato allontanato dal pool investigativo che lavorava a Palermo alla cattura di Matteo Messina Denaro con accuse gravissime. Ha poi subito diversi procedimenti giudiziari uscendone sempre però pienamente assolto.
Ci chiediamo come sia possibile che all’interno di un ufficio della procura spariscono dei computer?
Della denuncia fatta dall’ex finanziere Pulici si è mai indagato?
L’elenco non finisce qui!
Il maresciallo dei carabinieri Saverio Masi che è l’uomo che forse, più di tutti, è stato vicino alla cattura del boss Matteo Messina Denaro attività che il Masi avrebbe segnalato ai suoi superiori in pesantissime relazioni scritte, inspiegabilmente, da come si racconta, mai arrivate in Procura. Masi che poi sarà denunciato per una multa per eccesso di velocità.
La mancata verbalizzazione della riunione romana del 2 maggio del 1996 quando Caselli, il capo della procura di Palermo e Tinebra a capo della procura di Caltanissetta, alla presenza della dott.ssa Principato, non verbalizzò Ilardo, rimandandolo a Catania. Dove fu ammazzato.
Non dimentichiamo anche l’ex sostituto commissario della Dia catanese Mario Ravidà che ha lavorato sul campo con coscienza e tenacia anch’egli messo nelle condizioni di non lavorare.
È cosa nota ai nostri lettori i misteri che aleggiano sulle due relazioni di servizio prodotte dal Ravidà.
Una sul palazzo Graziano da dove, presumibilmente, si sarebbe potuto azionare il telecomando che provocò la morte di Borsellino e dei suoi agenti di scorta, relazione fatta sparire.
L’altra sulle rivelazioni che l’ex affiliato a Cosa Nostra catanese, Eugenio Sturiale, fece a Ravidà in merito agli esecutori dell’omicidio Ilardo, indicandone nome e cognome.
Ebbene, Ilardo venne ucciso il 10 maggio del 1996. Nel 2001, cinque anni dopo la morte di Ilardo, Ravidà, attraverso le confidenze di Sturiale, testimone oculare dell’omicidio di Ilardo, viene a conoscenza dei nomi e cognomi del commando che agì in via Quintinio Sella.
Ravidà mise tutto nero su bianco raccontando tutto quando gli aveva riferito Sturiale in una relazione di servizio che sebbene fosse stata mandata in procura, per diciassette anni, dal delitto Ilardo, la procura di Catania non ne seppe nulla.
A quanto pare la relazione non risultò mai in entrata nel palazzo della procura catanese e di conseguenza non fu mai parte degli atti che si riferivano dell’omicidio del confidente del colonnello Riccio.
In altri termini finì insabbiata in qualche carpetta di qualche ufficio o chissà dove. Quindi, chi indagava sull’omicidio Ilardo nulla sapeva di quest’importantissimo atto che segnalava gli autori dell’omicidio con nome e cognome e persino i mezzi usati per commettere il delitto.
Anche questa vicenda ci lascia l’amaro in bocca.
E mai possibile che nessuno, tra gli organi inquirenti o nei palazzi della procura catanese, sapesse dell’esistenza di una relazione di servizio firmata da un funzionario della Dia?
A questa domanda nessuno, ancora oggi, ha fornito delle spiegazioni che possano far luce su una vicenda che a definire incresciosa e poco.
Questa è la storia.
Una storia che parte da lontano che parte dai voti di scambio tra il PSI e Cosa nostra. Passa dalla caduta della Prima Repubblica. Si insinua nelle trame della trattativa. E arriva fino a noi. Dove la mafia si è inabissata, gli affari sono continuati, e i garanti del sistema si sono riciclati nei nuovi assetti di potere.
Vi abbiamo raccontato, seppur sommariamente, una serie di storie che non ce ne vogliano, sembrano collegate l’una all’altra.
Perché si insiste a svolgere processi frammentari che affrontano il singolo episodio?
Processi trentennali che con il trascorrere del tempo rendono i ricordi meno nitidi pesando sull’esito favorevole di una sentenza?
Perché non insistere su un unico processo che abbia ad oggetto il fenomeno nella sua complessità?
La mafia spara ma non comanda perché, forse, chi comanda davvero, ancora oggi, non è mai finito sotto processo.


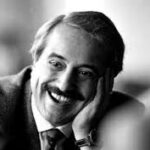



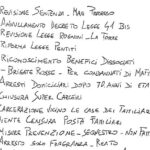










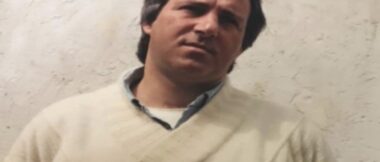
Grandissimo articolo!